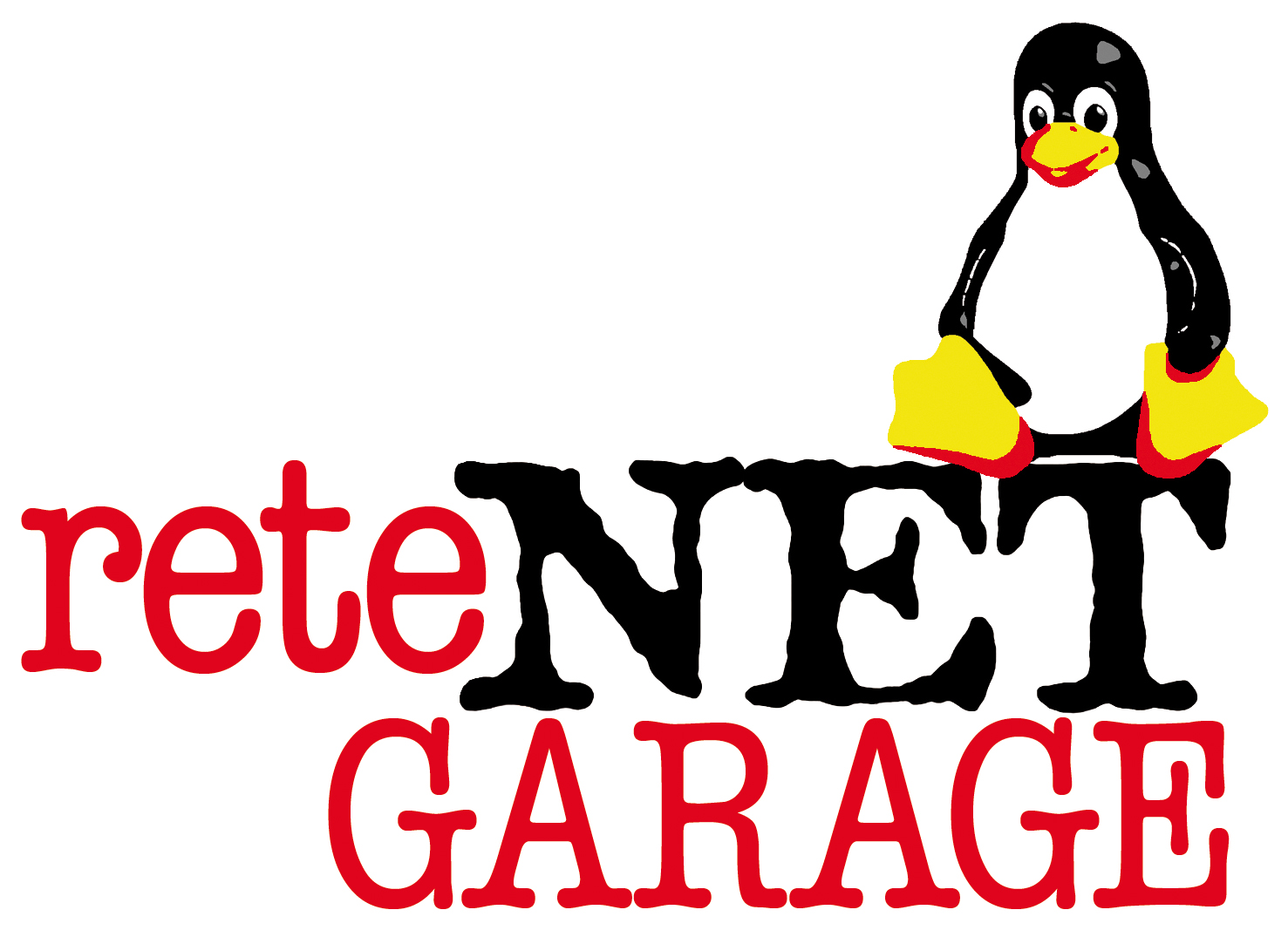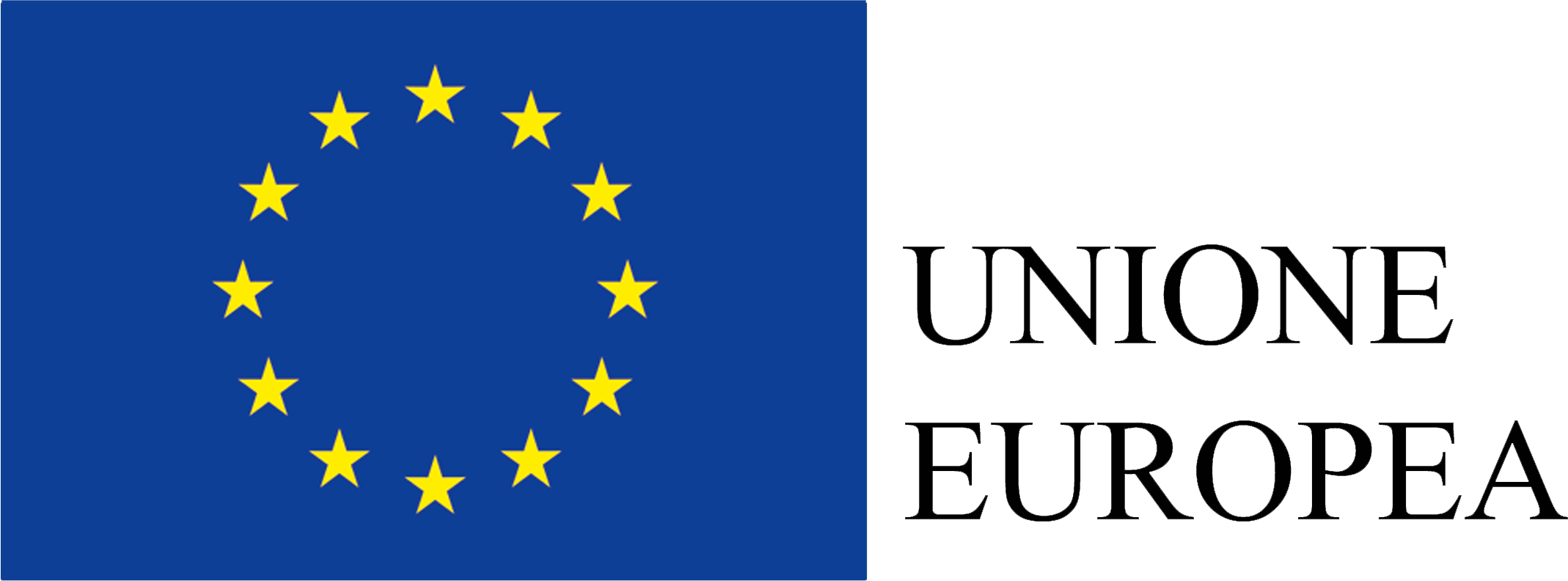ELENA ATTALA PERAZZINI
Stradanove intervista l'autrice del bel romanzo 'Tre stop a New York'

Fra vistosi bistrò modaioli, incombenti uffici immigrazione e art crimes notturni espletati in un teso clima antirepubblicano, le vite scriteriate di Susana, rocker scattosa e pittoresca, Micky, bel barista clandestino, e Benjiamin, “mammo” gay trentatreenne neo broker ed ex mormone, si incrociano sotto gli occhi increduli, inquisitori e a tratti divertiti di un' “obliqua spettatrice” d'origine italiana, dietro le vetrate di un locale dell'isola che non dorme mai.
Sul finale, in quel'11 settembre 2001 che cambierà di poco o molto le vite di tutti, qualcuno di loro si ritroverà, qualcun altro si perderà per sempre.
Stradanove intervista Elena Attala Perazzini, free-lance producer per Rai International, PR di Rainbow Room e infine assistente di Oriana Fallaci e scrittrice residente a New York dal 1997, che ci racconta le loro storie in Tre stop (più uno) assieme alla sua.
Il romanzo è vincitore del "Premio Internazionale Cartagine 2009" per la sezione Arte e Cultura.
“Tre stop a New York”: tre vite agitate e accidentate che convergono periodicamente nello stesso luogo, un locale del centro di Manhattan, sotto gli occhi di un'amica comune, la direttrice del ristorante nonché voce narrante del romanzo. Dove si stoppa l'autobiografismo per dare la precedenza all'invenzione letteraria?
Ho sempre scritto rifacendomi a storie vere, e lo stesso è accaduto per questo libro, nei cui ringraziamenti finali ho anche citato le persone reali dalle quali è giunta l'ispirazione per i personaggi letterari. Credo di non essere capace di scrivere dal nulla. Anzi, sono una scrittrice che non parte mai da zero: la mia ispirazione deriva dall'interazione diretta con le persone, dalla scoperta delle loro esperienze di vita; esperienze che amo raccontare, romanzandole, perché dentro le vite degli altri ritrovo sempre una piccola parte della mia. Le vicende di “Tre stop a New York”, pertanto, sono tutte giocate su storie vere e, seppur sullo sfondo di una dimensione inventiva di cui i meccanismi romanzeschi necessitano per poter funzionare, la parte autobiografica è assolutamente presente e palpabile. I personaggi principali e quelli collaterali si intrecciano e si incontrano in un locale di Manhattan che è in realtà il ristorante dell'East Village da me gestito per cinque anni, dove gli eventi narrati sono più o meno tutti accaduti. Nei tratti distintivi di queste figure c'è costantemente qualcosa di mio, e ripensando a loro rileggo anche un po' me stessa, comprendendomi meglio e capendo persino il perché del mio aver scelto New York come meta di attracco. Tengo tuttavia a precisare che ho ugualmente cercato di fare il possibile per rimanere al di fuori delle vicende narrate ed essere neutrale: per le autobiografie, infatti, c'è tempo, e quello dello psicoanalizzare se stessi non rientra fra i doveri primari dello scrittore.
Se i sei personaggi pirandelliani sono in cerca d'autore, quali sono i moventi e i propositi che animano i tre irrequieti protagonisti della tua storia?
Sono tutti immigrati sulle tracce del proprio Io, figure in cerca di sé in un altrove sconosciuto, decise nel voler vivere in un luogo distante umanamente e geograficamente da quello da cui provengono.
In ciascuno di loro c'è la ricerca di un rinnovamento continuo, di una vera e propria rinascita, con la cancellazione dei loro precedenti trascorsi. E questo umano desiderio di ininterrotto cambiamento non è banalmente riconducibile a un sentimento di noia o a un bisogno passeggero, ma è piuttosto un istinto evolutivo vero e proprio, un'esigenza atavica di comprensione personale che a New York è nell'aria e si respira ovunque, come se si volesse vivere più di una vita.
In un passo del libro scrivi che “senza un appartamento e un lavoro a New York si può finire barboni in pochi giorni”. Ma, nonostante le difficoltà dell'ascesa sociale in questa “giungla viva di cemento e luci”, i protagonisti del racconto dimostrano di essere legati alla città indissolubilmente, quasi in maniera simbiotica. Credi che ciò accada anche altrove o che si tratti, in qualche modo, di una prerogativa a marchio Big Apple?
Rispetto alla mia personale esperienza di vita in altre città del mondo come Roma, Londra e Madrid, credo di poter dire che si tratti di una qualità tipica di questo luogo, un carattere in grado di differenziarlo dalle altre grandi capitali, non per questo meno cosmopolite. A New York quasi nessuno vive con la propria famiglia: qui non ci sono bambini, né vecchi, perché chi mette su famiglia tende solitamente a lasciare Manhattan per stabilirsi in posti più tranquilli, a misura d'uomo e di nucleo familiare. A New York si è tutti immigrati, tutti stranieri: basti pensare che in quattordici anni di vita a Manhattan mi è capitato di conoscere solo una persona realmente nativa del posto. Vi è dunque una sorta di terreno comune entro cui muoversi: si è tutti arrivati da un altro luogo e si è tutti soli e bisognosi di un appoggio, di una presenza amica. A questo corrispondono molta solidarietà e altrettanta apertura da parte della gente, anche di chi non si conosce. Io stessa ho trovato i miei primi lavori attraverso perfetti sconosciuti: alla Raimbow Room, per esempio, sono arrivata grazie alla conoscenza casuale di una ragazza in un bar che, informandosi sul mio conto e domandandomi da quanto tempo fossi lì e per quali motivi, mi ha invitata a lasciarle i miei recapiti con la promessa di ricontattarmi per un posto alla reception. A me, che ero appena arrivata dall'Italia, pareva un approccio inconsueto, una dinamica strana: poi però quella telefonata è arrivata sul serio e di lì a poco ho avuto il mio primo, fortunato colloquio conoscitivo. Qualcosa di simile è capitato anche prima che diventassi assistente di Oriana Fallaci: la office manager di Rizzoli, amica di una giornalista con cui lavoravo, mi ha informata sull'esistenza di quell'opportunità, avvertendomi della presenza di altre quattro candidate ma esortandomi a tentare ugualmente, forte anche delle mie origini italiane. Così, a partire dal 1998, sono stata io l'assistente personale della Fallaci.
Oltre a quest'idea di solidarietà percepita, quando le porte della metropolitana si aprono e ci si ritrova ad essere una fra le migliaia di teste sgattaiolanti su per le scale, è altrettanto reale anche quel senso di alienazione di cui i tuoi personaggi danno prova in alcuni passaggi del racconto?
Sì, è proprio così. La solitudine, il senso di alienazione, l'idea di sfida, il sentirsi come piccoli scarafaggi fra le rocce di quest'imponente montagna di vetro e mattoni, è un altro degli aspetti da mettere in conto. New York è una città estrema, e lo è sempre, nel bene e nel male. E' una metropoli che impone la corsa, il darsi da fare: è così, correndo, facendo, che puoi trovare il sostegno e l'approvazione di tutti. Ma guai a fermarsi. E' questo, come detto, il luogo ideale per reinventarsi, il punto da cui partire per essere nuovi sul serio. E in tutto ciò New York è sui generis anche rispetto al resto degli States.
Il destino dei tre personaggi principali del libro si dimostra fatalmente legato a quell'11 settembre 2001 che avrebbe poi modificato, pur se in diversa misura, le loro storie e coscienze. Cosa ricordi di quel giorno? E, nove anni più tardi, quali pensi siano le tracce invisibili rimaste tuttora per le strade di Manhattan e fra i pensieri della gente?
L'aspetto di quel giorno di cui oggi sono più consapevole è, per paradosso, l'inconsapevolezza del momento: per noi che eravamo lì durante quella giornata, per chi ha lasciato il proprio ufficio e si è ritrovato per strada senza che dai ponti fosse più possibile passare, quel che è successo è stato troppo grande per rendersene conto nell'immediato. Ci si è tutti buttati per strada, nei ristoranti, nei locali, mossi da uno sconcertante senso di rifiuto, lo stesso cui faccio riferimento nelle ultime pagine del libro. E' surreale a ripensarci, ma ricordo che chi quella sera è venuto al mio ristornate ha parlato molto poco dell'accaduto: la paura vera è arrivata solo la mattina seguente, dopo averci dormito sopra ed essersi resi conto di cosa fosse realmente successo. A quel punto, ma solo a quel punto, abbiamo pensato di dover scappare, convinti che fosse tutto finito. Mi ero persino persuasa di dover chiudere il ristorante; invece, il boom: fino alla primavera dell'anno successivo gli incassi sono stati sorprendenti. La gente aveva bisogno della gente, le persone di stare fra le persone. Nessuno voleva rimanere solo. I media italiani hanno riportato cose diverse rispetto alla realtà dei fatti, raccontando che i newyorchesi non volessero più uscire, concludendo che avessero paura. L'atteggiamento della città, tuttavia, è stato completamente diverso: la ripresa è avvenuta in tempi rapidissimi, con una capacità reattiva insperata e inattesa. Ricordo che, appena una settimana più tardi rispetto al crollo delle torri, venivo invitata ad una festa da ballo indetta per agevolare una raccolta fondi. E subito si sono organizzati party, spettacoli, concerti: questo è il vero spirito americano, l'aspetto della loro cultura che più mi ha convinta e colpita. Se qualcosa di simile fosse accaduto a noi piagnucoloni europei non credo che la risposta sarebbe stata la stessa.
Fra i lavori che hai svolto a New York c'è stata anche l'attività di assistente per una delle più note e discusse giornaliste e scrittrici del secolo scorso: Oriana Fallaci. Che rapporto hai avuto con lei? La Fallaci: più donna o più Apocalisse?
Più donna, questo è sicuro, anche se non è stato facile lavorare per lei: le sue assistenti duravano in media tre settimane. Era una persona molto sola, isolata, una donna con un carattere inasprito e spigoloso ma capace anche di momenti di estrema dolcezza. Nei miei confronti la sua componente più umana ha prevalso: ci sono stati attimi in cui Oriana si è lasciata andare con me, e ci siamo ritrovate un po' come due amiche a chiacchierare a lungo. Poi capitava il giorno in cui mi si scagliava contro, gridando al telefono senza nemmeno farmi entrare dalla porta di casa. Ma a quegli episodi si sono sempre alternate parentesi indimenticabili. Io le ho parlato a lungo della mia passione per la scrittura e lei ha sempre cercato di mettermi in guardia, quasi disincentivandomi, ridimensionando le mie motivazioni: mi diceva che scrivere è un'avventura e che se avessi cominciato a farlo non avrei più potuto tornare indietro. Diceva che era come salire su un grosso carrozzone e affrontare un viaggio lungo e faticoso, fatto di profonda esplorazione interiore. Tuttavia, fra le righe dei suoi ammonimenti, io ho sempre intravisto un velato cenno di solidale incoraggiamento.
A quando nuove storie all'ombra dell'Empire e del Chrysler Building?
Sono al lavoro sul mio secondo libro dal mese di dicembre e la sua pubblicazione è prevista fra Natale 2010 e la prossima primavera: sto realizzando interviste ed incontri con personaggi italiani che si sono spostati negli Stati Uniti in diverse fasi della storia o della loro vita personale. Sono tutti immigrati che hanno fatto qualcosa di speciale nella propria esistenza, qualcosa di cui nel libro si parla attraverso la descrizione dei loro percorsi dal momento in cui hanno deciso di lasciare la patria a quello del loro primo impatto con la nuova realtà, sia essa New York o un altro luogo d'America. L'ultima pagina di ciascun racconto svela invece al lettore che fine hanno fatto, nel 2010, queste persone: ci sono storie di grandi successi ma anche casi di completo fallimento. E' un lavoro molto appassionante per me, sopratutto perché mi consente di percorrere quella via mediana fra il giornalismo e la narrativa saziando la mia smania di nuovi imput e presentandosi come uno spaccato societario interessante: le età degli intervistati sono infatti diverse (il più vecchio è un famoso drammaturgo, l'autore del musical “Nine” da cui nel 2009 è stato tratto l'omonimo film, trasferitosi a New York negli anni '60 e oggi ottantunenne) e altrettanto diverse sono le motivazioni che hanno spinto ciascuno di loro a procurarsi un biglietto di sola andata per la Grande Mela.
 LA VIA DI COMUNICAZIONE PER I GIOVANI MODENESI
LA VIA DI COMUNICAZIONE PER I GIOVANI MODENESI