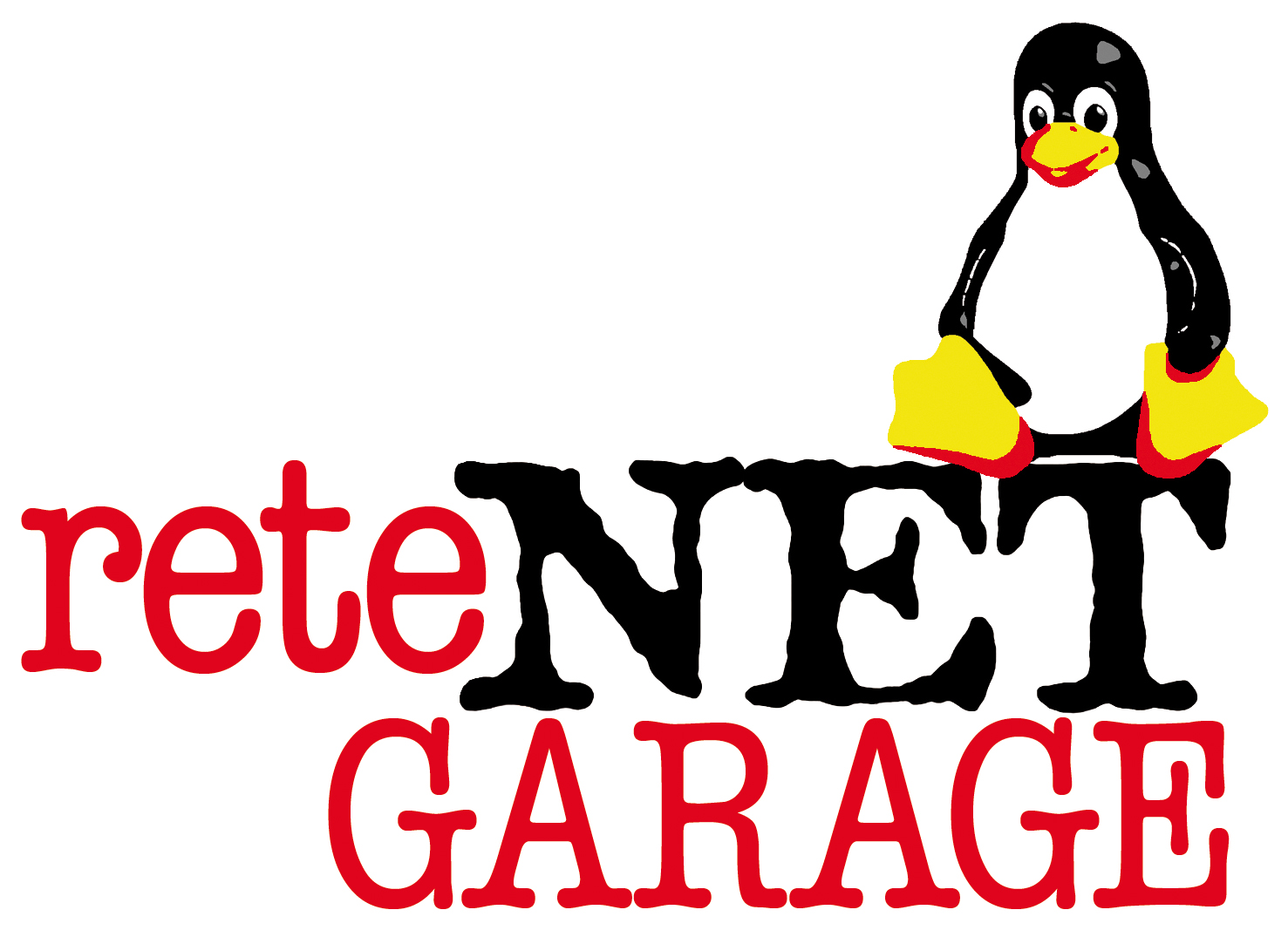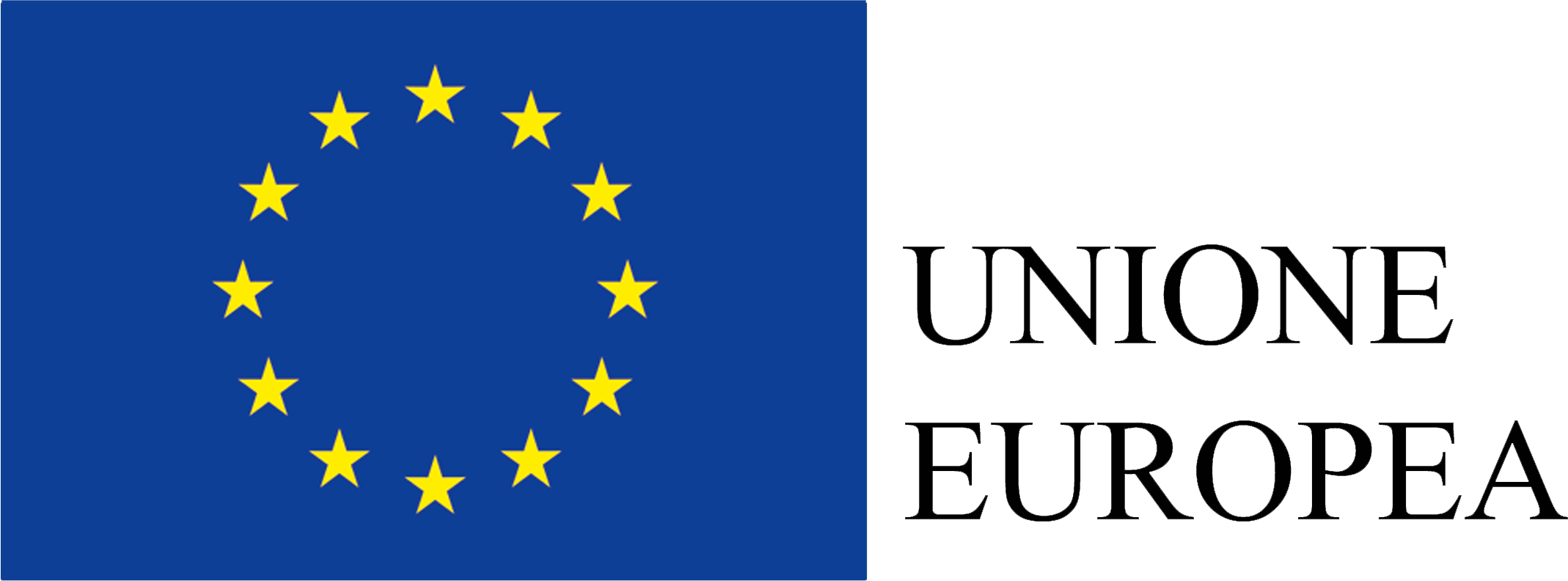MASSIMILIANO ARAVECCHIA
“C'è speranza finché ciò che scrivi ti delude”. Chiacchierata con un giovane poeta modenese

Massimiliano Aravecchia, classe 1983, vive in Canada dal settembre 2011 dove svolge un Ph.D. in French Studies presso la Western University.
Tra le tue passioni ci sono la poesia e il teatro: per anni ha collaborato con l'associazione culturale "Arcoscenico", con cui ha messo in scena diversi spettacoli.
Ha pubblicato versi, su rivista ("Le voci della Luna") e recentemente in un libro, "La valigia e il nome" edito presso “L’arcolaio” di Gianfranco Fabbri; tra i premi vinti "Il lago verde", "Concorso Guido Gozzano", "Premio Renato Giorgi" e "Under29".
Perché hai deciso di trasferirti all'estero? Hai intenzione di ritornare a vivere a Modena oppure no?
Gioco subito la carta del fatalismo: vengo dalla montagna, l'emigrazione ce l'abbiamo dentro. E non tanto per vedere posti nuovi, ma per un'ansia di lavoro e realizzazione che il paese non può offrire. Il Canada non è la prima tappa (che fu sconvolgente: a 13 anni, scendere a Modena per frequentare il liceo) e non sarà l'ultima. Credo che i motivi siano sempre gli stessi; la mia storia non si discosta in fondo da quella di un'intera generazione in fuga dall'immobilismo italico.
Quanto al ritorno... a Modena torno spesso con la memoria. Ma la città che amavo (sì, dirò una cosa forse impopolare tra i miei coetanei, ma io a Modena ho voluto bene per gran parte della mia adolescenza) non esiste più. Se n'è andata, oggi è una fotografia sfocata – ma non è lei ad essere mossa, sono io. Non è necessariamente un male: coltivo le mie radici nella memoria.
Teatro e poesia, due mondi ed espressioni artistiche apparentemente contrapposti: stando ai luoghi comuni, il teatro evoca il lato più esibizionista ed istrionico della personalità umana, mentre la poesia ne richiama il lato interiore, più intimo...
Dal mio punto di vista esiste tra i due un dato comune (come per altre forme espressive) ed è il desiderio di mettersi in piazza, il piacere un po' narcistico di offrirsi allo sguardo e al giudizio degli altri. C'è un momento in cui i balbuziamenti post-adolescenziali prendono forma “pubblica”, almeno nelle intenzioni, e si sviluppa nel poeta la folle speranza di risultare “interessante”, di essere compreso, di entrare in contatto con altre solitudini. Il teatro si gioca sullo stesso scambio di emozioni, più potente per colui che lo riceve perché tutto passa per gli occhi, forse meno per colui che lo propone, che segue un copione, un percorso di cui non è necessariamente l'autore, e da cui si fa “spossessare” ad ogni istante. Con la poesia sei meno protetto: nel momento in cui leggi o ti fai leggere da altri, sei un po' più nudo, un po' più solo.
Di cosa parlava la prima poesia che hai scritto? E l'ultima?
Credo di aver cominciato, come ogni poeta, da una delusione d'amore. Non è la prima poesia che ho scritto, perché mi pare di averne sempre avute in testa, ma è la prima che ricordi: avevo probabilmente 14 anni e mi chiamavo cliché. In realtà non c'è una prima poesia o un'ultima: c'è un rovello continuo, un'insoddisfazione che porta a scrivere, riscrivere, correggere, limare... spesso a cestinare. Ecco, l'ultima è una poesia che non ho scritto. Una poesia che ho pensato, come per un'illuminazione, e che nelle mie intenzioni chiudeva un discorso nel mio libro; una poesia che, ti assicuro, era chiara, addirittura evidente nelle intenzioni; ma che si è dissolta al momento di metterla per iscritto. Capita. Quella è l'ultima, e non è stata. Ma forse sarà, e sarà la prima di un ipotetico nuovo percorso.
Di cosa ti piace scrivere e di cosa non ti piace scrivere?
Temo che la domanda vada posta in altri termini: di cosa sai o non sai scrivere? Oppure, di cosa puoi e non puoi scrivere? Il punto è che la poesia fa quello che vuole e il fatto che io desideri scrivere su un tema in particolare non conta granché quando si tirano le somme e la voce prende corpo. Io piango ogni volta che leggo “Fabrica” di Fabio Franzin, ma non saprei fare altrettanto: c'è un problema di vissuto, alla base, e poi c'è un problema di educazione alla scrittura, di lavoro sulla propria voce. Vorrei saper scrivere un libro come “L'opposta riva” di Fabiano Alborghetti, e vorrei assestare pugni nello stomaco come fanno molte poesie di Matteo Fantuzzi. E questi sono poeti giovani e attivi, poeti che ho ascoltato, conosciuto, con cui c'è stato un qualche confronto; perché, altrimenti, certo, tutti vorrebbero essere il nuovo Rimbaud. Ma non è quello il punto. È che il mio essere poeta, mi pare, (ri)nasce spesso come tensione verso ciò che non è, che non potrà essere. Ho un modo di pormi, rispetto alla mia materia, molto elegiaco (ovvero di colui che fa entrare il mondo intero nella propria esperienza di vissuto), ma lavoro sulla mia voce, su alcuni dati non più oppugnabili dopo il Novecento (ad esempio la tensione prosastica). Poeticamente ho un percorso molto chiaro, addirittura evidente (ma accade spesso negli esordi), eppure cerco da leggere le esperienze più lontane, di lavorare su questa distanza. Il punto d'arrivo è una poesia che non scriverò mai, in cui saranno immediatamente chiari i debiti col passato (perché stringi stringi sono un classicista, e risento sempre della grande lezione dei padri) e al tempo stesso il mio essere nuovo. O forse non c'è un punto d'arrivo, la meta del viaggiare è il viaggio stesso: da questo punto di vista vale sempre quella frase di Sbarbaro che dice suppergiù: “c'è speranza finché ciò che scrivi ti delude”. Ecco in definitiva, per risponderti: l'unica cosa di cui so scrivere è me stesso, ovvero il frammento di società che conosco meglio. Così scrivo di me stesso, sperando a volte di annusare quel qualcosa che tutti abbiamo in comune e che è l'obiettivo nascosto di ogni poeta.
Hai, tra quelle scritte da te e non, una poesia preferita?
Tra quelle che ho scritto io non saprei scegliere. L'altra sera ero al supermercato, tardi, verso mezzanotte, e c'era una ragazza che sceglieva una piantina. Una sola cassa aperta, il cassiere con gli occhi arrossati dalla stanchezza, e tutti che aspettavano che lei scegliesse questo fiore da nulla da aggiungere alla propria spesa. Ora, per qualche miracolo, la ragazza in questione non aveva fretta: ogni sua attenzione era dedicata esclusivamente allo scegliere il fiore più bello tra quelli, in verità assai miserevoli, accanto al reparto frutta e verdura. Ecco, ogni volta che scrivo una poesia scelgo il mio fiore tra altri fiori da nulla, e ogni volta provo a fare come quella ragazza, a dimenticare il mondo attorno. Ogni volta penso di aver fatto tutto ciò che, fin lì, potevo fare. Ovviamente consapevole del fatto che il mondo è pieno di fiori splendidi accanto ai quali la mia piantina impallidirebbe. Se invece mi chiedi una poesia o un verso altrui, tra i tanti che amo c'è un'ottava di Emilio Rentocchini, forse non tra le più famose, che parla di un tizio in bilico su un ponte in una città straniera, intento a guardare l'acqua che corre via. Quell'ottava è come l'acqua che guarda il protagonista, Andrea Mina: hai l'impressione di averla capita, di aver udito ciò che gorgogliando passa di verso in verso, e mentre cerchi di formularlo fuori dall'impressione, è già fuggita via. Così, come tutti i personaggi rentocchiniani, anche Andrea Mina (che sarà in qualche misura l'autore, che è sicuramente il lettore) resta lì, nel vuoto creato dall'ottava, come fissato in una posa di goffo eroismo, col significato che gli sfugge tra le dita. Nulla di nuovo sotto il sole della poesia, mi diranno: ma il fascino della poesia di Rentocchini è proprio questo. Il distico finale, che è poi quello che mi rimane sempre in testa come un ritornello, dice press'a poco: “E intant la not la tàca la rapina / E a's porta via pian pian anche Andrea Mina”.
"La valigia e il nome" è il titolo della tua prima raccolta di poesie: cosa ci troviamo dentro?
Una pluralità di oggetti difficilmente circoscrivibile al di là del criterio soggettivo che li ha prodotti, del percorso che ho compiuto in questi anni e di cui il libro porta una traccia, in modo diaristico, come spesso accade ai poeti giovani. Nelle mie intenzioni era partito come un libro con un tema centrale “forte”, a cui sacrificare tutto, e questo tema era la memoria. Poi, non saprei: ma mi sembra che – come spesso mi accade quando preparo una valigia – ci abbia messo dentro anche oggetti disparati, che mi dicevo sarebbero tornati utili e forse sono piste morte, che torneranno a casa come le magliette ancora con la piega del ferro da stiro. C'è la memoria, declinata in molti modi: la mia e quella di altri, degli antenati, che è divenuta mia tramite il racconto. E poi c'è il viaggio, attraverso lo spazio ma anche attraverso il tempo – un po' come Pitea, che in epoche antiche viaggiando verso nord incontrò ad un certo punto il luogo in cui il mare e il cielo si saldavano in una nube che lui chiamò « polmone marino ». Ecco, nel libro c'è il tentativo non di raggiungere, ma di muoversi verso questa specie di “tasca” al fondo della quale spazio e tempo si confondono.
Sono di Modena, la tua città, diversi poeti riconosciuti tra le nuove e le vecchie generazioni...
Sì... Ho citato Emilio Rentocchini, ora aggiungo Andrea Gibellini, una delle voci che più sento affine nella generazione dei “padri” (anche se, per un triste vezzo tutto italico, qualcuno potrebbe etichettarlo come giovane poeta), uno dei miei lettori più severi, e per questo più preziosi. Alberto Bertoni è un altro grande nome, un punto di riferimento per molti giovani poeti. E poi permettimi di menzionare Milena Nicolini, a cui per anni ho portato i miei versi, che tornavano indietro pieni di correzioni, cancellature, punti esclamativi ed incoraggiamenti: la mia concezione di poesia si è forgiata essenzialmente nel rapporto, mai banale, con Milena, voce appartata ma notevole nel panorama che ci circonda. A lei devo in parte ciò che sono diventato, non solo o non tanto poeticamente – può valere come un omaggio o come un atto d'accusa. Tra i poeti della mia generazione, senza uscire dai confini provinciali, sono affezionato a Marco Bini di Vignola, che ha all'attivo un bell'esordio, un libricino che ha avuto il meritato successo. E soprattutto a Guido Mattia Gallerani, critico finissimo e poeta di inusitata potenza: lui, che è per me una sorta di alter-ego poetico, è il responsabile della prefazione che apre la mia opera prima, e che mi fa arrossire ogni volta che la leggo.
Perché scrivere poesie nel 2012?
Perché la poesia è una necessità. È un bisogno, fisiologico innanzitutto. Un caro amico una volta mi ha detto: la poesia è come la pipì. Quando scappa bisogna farla.
 LA VIA DI COMUNICAZIONE PER I GIOVANI MODENESI
LA VIA DI COMUNICAZIONE PER I GIOVANI MODENESI