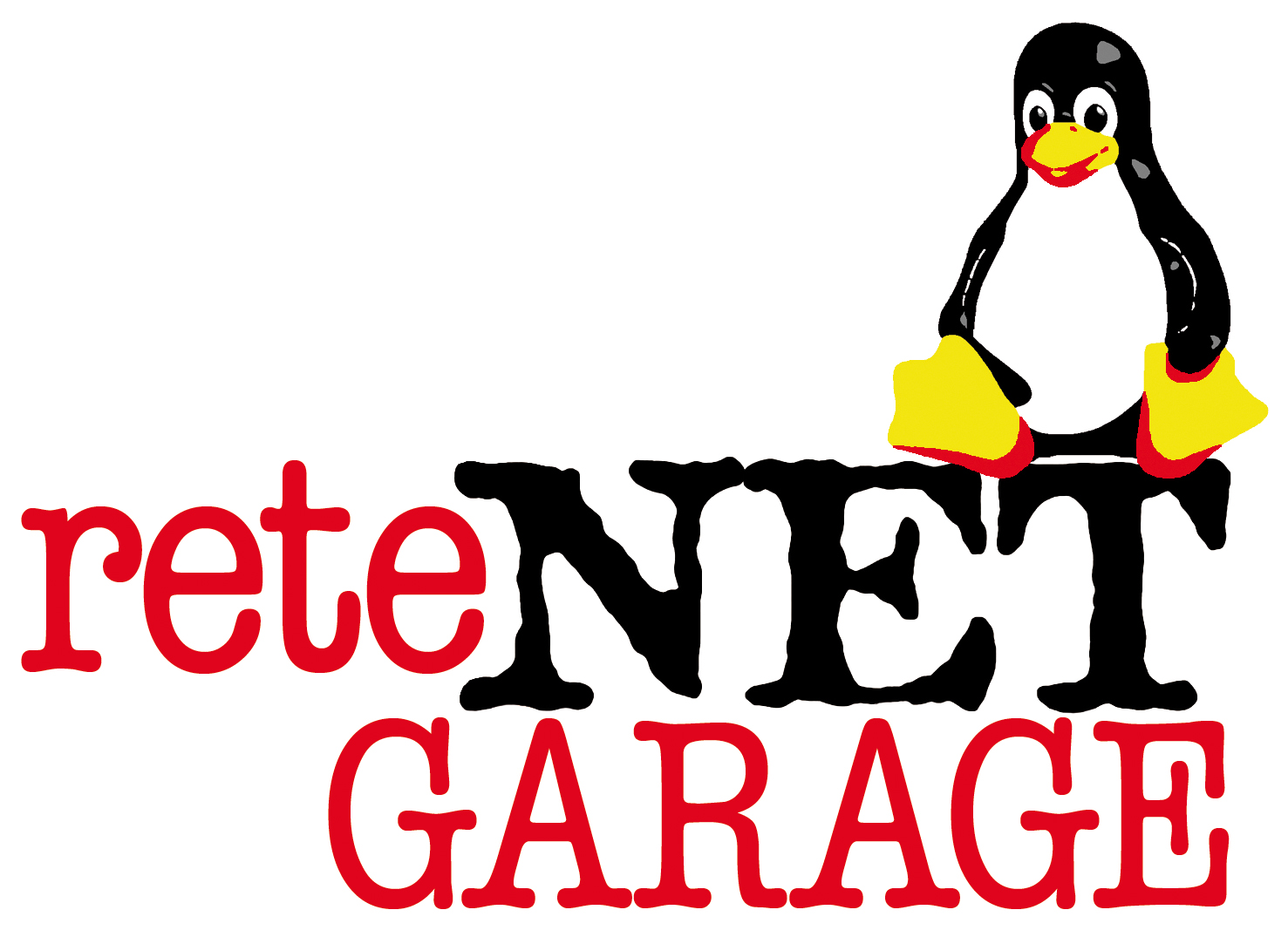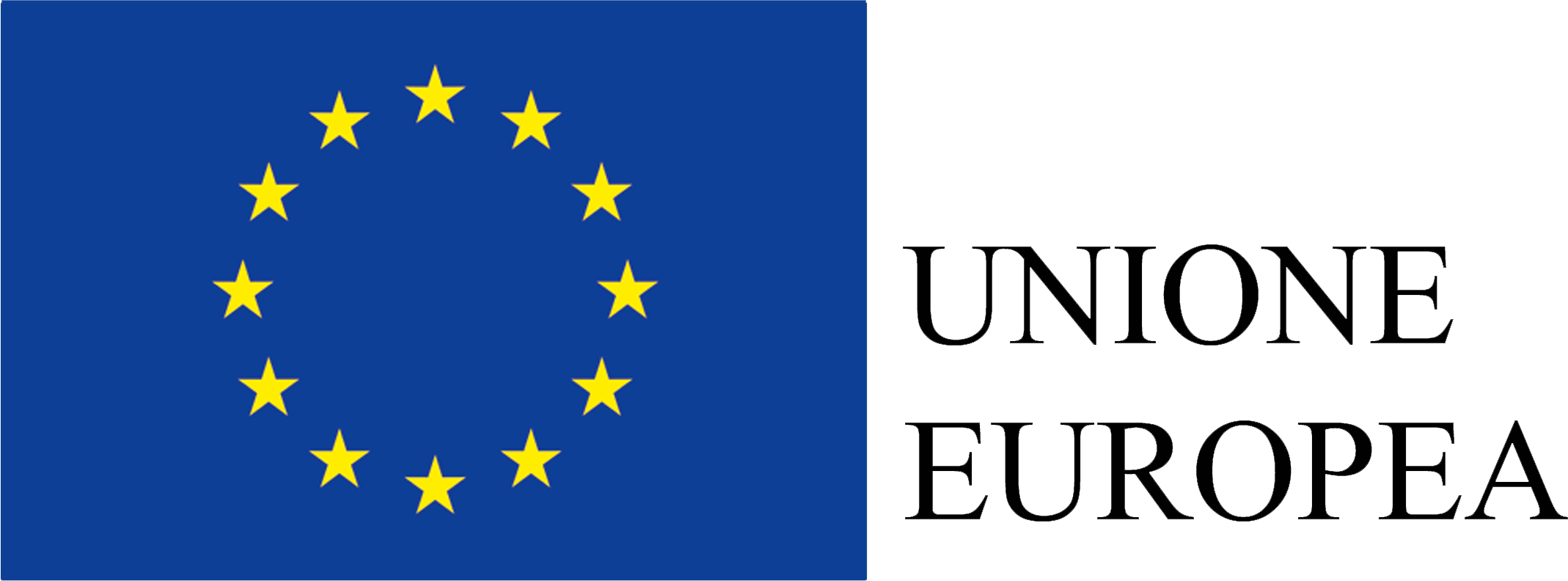FRATTURE, IRIT AMIEL
Storie di ‘scottati’ per non dimenticare

Parla di vite spezzate, di fratture, questo esile, bellissimo libro della scrittrice ebrea polacca Irit Amiel. Ne è un esempio- il più lieve, il più piacevole- il suo stesso nome che non è quello che le hanno dato i suoi genitori, in Polonia. Lo spiega in uno dei racconti che formano il libro, senza dirci che è di sé che sta parlando: arrivando in Israele, tra gli scampati al rogo, al massacro, all’immane tragedia della Shoah, una ragazza deve cambiare nome, prenderne uno più consono al nuovo e orgoglioso paese in cui è sbarcata. Non è facile cambiare nome, è come cambiare identità, separarsi del tutto dai genitori che le hanno dato quel nome e che sono stati assassinati a Treblinka. Il suo vero nome è Irene. Si chiamerà Irit- suona un po’ come Irene, nevvero?
Se sono ambientate nel presente, le storie contenute in “Fratture” ci parlano di persone ormai anziane, di coloro che erano bambini nelle storie che si svolgono nel passato- storie incredibili di chi si è salvato, per un caso, per la previdenza dei genitori, per l’umanità e la generosità (normali in tempi normali, straordinarie in tempo di guerra) di persone da cui non ci si sarebbe aspettato che mettessero a rischio la loro vita per salvare quella altrui. Molti dei personaggi sono di Cestocova, la cittadina in cui vivevano trentamila ebrei prima della guerra: cinquemila tornarono a casa.
Tra loro Fania, la bambina che si è salvata con documenti ariani, e che arriverà in un kibbutz dopo un viaggio lunghissimo passando da Danzica. Fania era stata ‘scottata’, come la mamma del giovane che lavora in un’agenzia di viaggi in un altro racconto e che deve nascondere ai genitori di avere a che fare con i tedeschi per motivi di lavoro. Quando- e sono passati quindici anni da quando lui ha conosciuto la rappresentante di una grossa agenzia turistica tedesca- sua madre incontra la donna, la riconosce: l’aveva già vista in visita nel ghetto e poi mentre si affrettava a fuggire in America Latina.
I racconti di Irit Amiel hanno sempre un tono pacato, una lievità di narrazione che è il controcanto della drammaticità di quello di cui parla- una bambina di due anni (due anni!), denunciata e portata in carcere, un’altra bambina di dieci anni rimasta da sola in casa, la madre che rifiuta la morte del figlio e si fa spedire lettere dal Brasile, inventando una vita per il figlio-, impiegano immagini e un linguaggio che a volte paiono ariosi, sono vicini alla poesia. Irit Amiel non parla di sopravvissuti, ma di scottati, riuscendo, con una sola parola ad evocare i morti bruciati nei forni e i vivi che hanno riportato ustioni nell’anima nei campi della morte. Irit Amiel parla di vivi e di morti che continuano a vivere nella memoria dei vivi- anzi, questa è la loro unica possibilità di vivere l’esistenza che è stata loro troncata.
Irit Amiel parla ai morti come se non avessero mai lasciato questa terra attraverso i camini, presenta loro i figli e i nipoti- la loro vittoria su chi voleva cancellare gli ebrei dal mondo. E queste ombre che prendono il tè non viste insieme ai giovani discendenti (quanto lontane dai vampiri o dagli zombie della letteratura dell’orrore) affidano loro un undicesimo comandamento: è un ordine, Ricorda, come i primi comandamenti delle Tavole di Mosé; oppure una proibizione, come gli altri comandamenti, Non dimenticare.
Chi pensava che non ci potessero essere altre maniere per parlare dell’Olocausto, dovrà ricredersi. Il libro è nella terna dei candidati al premio ADEI WIZO.
Irit Amiel, Fratture, Ed. Keller, trad. Marzena Borejczuk, pagg. 139, Euro 13,50
 LA VIA DI COMUNICAZIONE PER I GIOVANI MODENESI
LA VIA DI COMUNICAZIONE PER I GIOVANI MODENESI